“A furriata di torci”
Durante la festa del Crocifisso di Ciminna, che si tiene la prima domenica di maggio, è tradizione la processione delle torce: cosiddetta furriata ri torci.
Come è noto, la processione delle torce, oggi, comincia alle 15:00 del pomeriggio della domenica, da Piazza Alcide De Gasperi, procede per la via Dott. Vito Graziano e finisce davanti la chiesa di San Giovanni Battista; è preceduta da uno stendardo, cui fanno da seguito giumente delle razze più disparate arrivate per l’occasione dai paesi vicini, sulle quali i fantini portano una torcia (ormai quasi nessuno) o una ghirlanda intrecciata di fiori.
segue la , cioè sette muli (più spesso cinque, data la difficoltà ormai di reperire questi animali), agghindati a festa con sonagli sul capo e sulla coda, bardati con le piene di cuppitedda, cioè coppettini di confetti, caramelle, cannellini e cioccolatini, che i guidatori dei muli lanciano tra le persone accorse durante il passaggio delle retini per le vie del paese oppure nella piazzetta davanti la chiesa di San Giovanni, dove i guidatori delle rétini abilmente fanno girare (furriari) i muli a cerchio e continuano a lanciare alla folla i dolcini e le cianfrusaglie (portachiavi, accendini, etc.) contenuti nelle bisacce. Segue il corteo la .
Usanza importante, che ci servirà a decifrare questa consuetudine dei Ciminnesi, è questa: che i guidatori dei cavalli, arrivati davanti la chiesa di San Giovanni, si scoprono il capo, si fanno il segno della croce e consegnano alla Chiesa la torcia o la ghirlanda che recano in mano.
La processione delle torce, così come la conosciamo noi, è menzionata per la prima volta nel 1842: prima che si trasformasse in questa usanza, la processione, a detta di Graziano, consisteva nel viaggio durante l’anno fatto dai contadini che recavano «agnelli, capretti, piccioni, galline, lana, cacio denaro, torce di cera ed altro». [Graziano, V., Canti e leggende-Usi e costumi di Ciminna, p. 76.]
Inoltre, ai fini della comprensione di questo rito, occorre sapere che nel passato le bisacce erano piene di frumento dato in elemosina al Crocifisso, usanza che, nota il Graziano, «si fa in tanti altri paesi per ringraziare il Santo del raccolto abbondante e per grazie ricevute».
Credo che per un’analisi corretta di questo rito dobbiamo prendere le mosse proprio da ciò che c’è dentro le bisacce della furriata di torci e poi via via risalire al senso della torcia stessa, da cui questa usanza prende il nome.
Il fatto che le bisacce un tempo portassero, oltre ai confetti e ai dolci, il grano in offerta al Crocifisso e che oggi il grano non figuri più si spiega facilmente se si considera che un tempo il denaro circolante era poco e che al suo posto si usava scambiare il : le offerte per grazia ricevuta o per “raccolto abbondante” (leggi: cospicuo guadagno), consistono adesso in banconote appese sullo stendardo della processione del fercolo che avviene le sere della domenica e del lunedì.
Ebbene il fatto che le bisacce (vertuli) siano piene di leccornie e che un tempo fossero piene di frumento, non può non far pensare alla cornucopia, attributo della dea pagana dell’Abbondanza/Opis/Annona/Demetra/Cerere (In realtà queste divinità agli occhi dei moderni appaiono sovrapponibili e interscambiabili, ma nell’Antichità avevano culti e riti differenti). Demetra e Cerere, infatti, sono le dee (greca la prima e romana la seconda) che erano considerate dagli Antichi protettrici delle messi, del raccolto del frumento e dei in genere.
Demetra, chiamata dai Latini Cerere, è un nome che vuol dire e gli Antichi pensavano che fosse una divinità molto venerata in Sicilia, dal momento che la figlia di quest’ultima, Persefone, chiamata anche Proserpina o Kore, fu rapita dal dio degli Inferi Ade proprio in Sicilia, mentre giocava con alcune ninfe: il mito narra che la madre Demetra la cercò in tutto il mondo e, ospitata da Celeo, re di Eleusi, per riconoscenza nei suoi confronti, insegnò le tecniche della coltivazione dei cereali e dell’agricoltura in generale al figlio del re, Trittolemo, affidandogli il compito di dispensare questa conoscenza a tutti gli uomini. È questo il motivo per cui i Greci veneravano la dea Demetra con i Misteri eleusini, festività che si tenevano due volte all’anno, nei mesi autunnali e primaverili e con le Tesmoforie ad ottobre; i Romani invece festeggiavano ad aprile i Cerealia, in onore della dea Cerere: in tutte queste festività che si svolgevano nei , si offrivano alla dea Demetra/Cerere le primizie dei frutti della terra e sacchi di frumento, in segno di ringraziamento e lo portavano la sacra torcia della Dea, cioè la torcia con la quale Demetra/Cerere era andata in cerca della figlia perduta.
Risultano relazioni tra la ricerca di Demetra della figlia morta e la cerca della Madonna la notte del Venerdì Santo del figlio Gesù morto e tutta la simbologia legata ai due culti sembra avere tratti in comune: la morte della natura e la rinascita della stessa che rispecchia perfettamente la discesa agli Inferi di Proserpina nel periodo dell’anno dell’autunno-inverno (morte di Cristo) e la sua ascesa al mondo dei vivi nel periodo della primavera-estate (Pasqua di Resurrezione).
Al di là di queste connessioni più o meno studiate e più o meno lapalissiane, quello che importa notare a proposito della furriata di torci è che:
- l’usanza di offrire primizie dei frutti della terra portate dentro le bisacce al Crocifisso e, nella fattispecie, il frumento, è chiaramente figlia dell’usanza che gli Antichi avevano, durante i Misteri eleusini, in Grecia, e durante la festività dei Cerealia, a Roma, di offrire sacchi di grano alla Dea Demetra/Cerere: questo rito, infatti, come dice anche Graziano e come si può notare andando in giro per la Sicilia, è presente in molte feste di paese che si svolgono a maggio e sono dedicate al SS: Crocifisso;
- per quanto riguarda la torcia, da cui l’usanza ciminnese prende il nome, possiamo dire che:
- sembra forzato il riferimento alla Sacra torcia, portata dal daduco durante le feste in onore di Demetra/Cerere: la torcia pagana era ricordo della torcia che la Dea aveva utilizzato per cercare la figlia Persefone[Cfr. Cecilia Gatto Trocchi, Enciclopedia illustrata dei simboli, Gremese editore, 2004, s.v. Torcia.]; nella simbologia cristiana, invece, la torcia, è uno degli strumenti della Passione di Cristo: simboleggia la torcia utilizzata dai soldati romani quando arrestarono Cristo[Cfr. Giovanni, 18, 3 e Michel Feuillet, Lessico dei simboli cristiani, Edizioni Arkeios, 2016, p. 119, s.v. Torcia.] e per questo motivo la connessione tra simbolo pagano e simbolo cristiano diventa impossibile; inoltre non mi pare che la torcia utilizzata durante la furriata ri torci serva a ricordare uno strumento della Passione: il suo significato, quiundi, va ricercato altrove;
- la parola torcia, derivata dal latino torquere (avvolgere, intrecciare), consisteva anticamente in un «bastone di abete o di altro albero resinoso circondato da uno stoppino di cera»[Cfr. Domenico Passantino, Simbologia, iconologia e allegoria in opere di Paolo Amato, in Estetica e retorica del Barocco in Sicilia, vol. I, a cura di Vito Mauro, 2017, p. 164, nota 13 e sgg. La torcia, portatrice di luce, fu creata da Dio, nel Vecchio Testamento (Esodo, 13, 21) per guidare gli Ebrei, fuggiti dall’Egitto, verso la Terra promessa.]: il suo uso, che è quello di fare luce, ci porta immediatamente a pensare che essa, nel nostro caso, simboleggi Gesù Cristo luce del mondo, se si pone mente, per esempio, al Cero pasquale, che simboleggia il Cristo risorto e vincitore sulle tenebre della morte e del male: Cristo viene omaggiato con la torcia, che è ringraziamento per la vita tornata sulla terra, simbolo della Resurrezione divina e naturale, Resurrezione la cui prova sono il frumento e le primizie della terra portate in dono.
Infine si potrebbe pensare che il fatto che i muli girino in cerchio, forse un po’ surrealisticamente o forse no, sia da riferirsi analogicamente al tempo ciclico dell’anno, all’alternarsi delle stagioni che si ripropongono a giro, ciclicamente: Gesù Cristo che muore e poi risorge, Proserpina/Kore/Persefone che discende agli Inferi e poi ascende sulla terra, la natura che muore e poi rinasce, il grano che, se non va sotto terra quando viene seminato, non può produrre frutto; proposizioni che si sintetizzano in una sola di significato universale: per fruttificare e farsi messe, il grano deve morire.
Una simbologia antica di secoli e millenni, che rispecchia una concezione del tempo ciclica a : sono indicatori di questo rischio reale dell’estinzione del senso del tempo il fatto che il frumento non viene più usato, in conformità alla distanza che oggi separa l’uomo dalla terra, e la consapevolezza del significato di questi riti che viene via via a mancare, lasciando solo la sterile tradizione priva di significato che si modella negli anni alle mode della globalizzazione, mode che distruggono le peculiarità e l’identità dei singoli popoli.
Fa un certo effetto, d’altro canto, vedere scorrere la processione della furriata r’i torci, nella quale usi, costumi e simboli cristiani si sovrappongono ad usi e costumi ebraici e pagani, un sincretismo di culture religiose che si sono sommate nel tempo le une alle altre fino a fondersi insieme: dai Greci ai Romani e agli Arabi, passando per gli Spagnoli.
A cura di Domenico Passantino
Foto di copertina di Giuseppe Avvinti


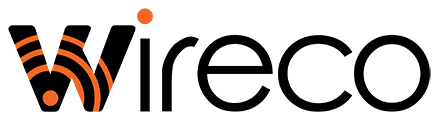





Aggiungi un commento